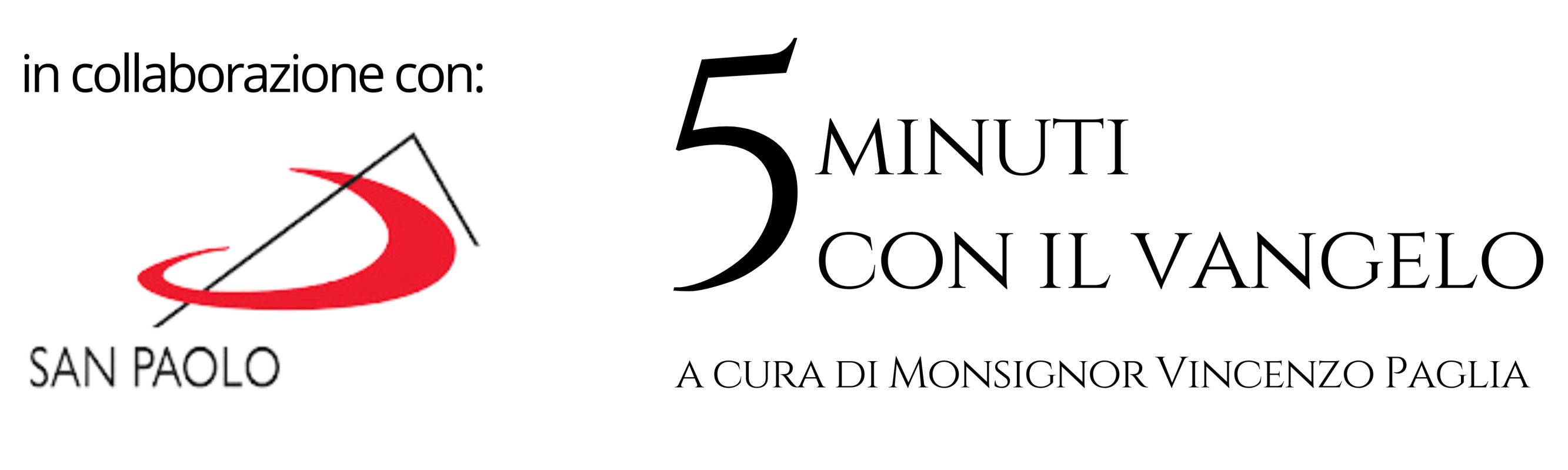Maestro elementare dal 1975, Marco Rossi-Doria ha insegnato in quartieri difficili di Roma e Napoli, ma anche all’estero e in particolare negli Stati Uniti, Kenya e Francia. Primo maestro di strada, ha fondato il progetto Chance, scuola pubblica di seconda occasione. Ha ricevuto dal presidente della Repubblica la Medaglia d’oro per la cultura, l’educazione e la scuola nel 2001. Dal 2021 è presidente dell’impresa sociale Con i Bambini. A lui chiediamo quali sono le sfide dell’educazione oggi, in occasione del Giubileo del mondo educativo.
Marco Rossi Doria (Foto: “Con i Bambini”)
Quali sono, secondo lei, le maggiori sfide dell’educazione oggi?
Ci sono ancora disuguaglianze materiali. Parlando di Giubileo e quindi con uno sguardo al mondo, tanti bambini sono ancora fuori dall’educare, in senso strutturato, dalla scuola. Certamente sono aumentate le iscrizioni e le frequenze della scuola. Negli ultimi 50 anni c’è stato un enorme progresso, però rimangono centinaia di milioni di bambini e ragazzi che vanno poco a scuola o non ci vanno proprio nelle zone povere del nostro pianeta, soprattutto le bambine. La povertà è poi multidimensionale, non è solo economica, ma abitativa e mancanza di occasioni compensative capaci di inverare i diritti. Anche in Italia, anche nei Paesi ricchi c’è ancora una corrispondenza tra il fatto di nascere con meno mezzi economici in un quartiere più povero, in periferia, e non accedere alle opportunità e avere maggiori insuccessi scolastici. Questo significa che la scuola e il successo formativo hanno una caratteristica fortemente classista, nonostante tutti gli sforzi che ognuno di noi fa, anche la Repubblica e l’Europa nel suo insieme fa. Quindi abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere:
bisogna dare di più a chi parte con meno, perché l’eguaglianza formale, dare a tutti la stessa cosa, come ha detto a suo tempo don Milani, copre la disuguaglianza sostanziale.
Pensando alle nuove tecnologie, al digitale, alla rete che non c’è dappertutto, ci possono essere ulteriori fattori che creano disuguaglianze?
Sicuramente, c’è ancora fortissimo il digital divide, la rete non c’è per tutti allo stesso modo, ma non è l’unico problema. Bisogna considerare i rischi di stare attaccati al telefonino tutto il giorno, le neuroscienze attestano di una vera e propria dipendenza patologica, perché entrano in sinergia con le sinapsi del nostro cervello anche in termini biochimici. Diventa necessaria non solo una vigilanza, ma anche una serie di proposte per cui ridare senso al gioco collettivo in cui corpo e mente possono giocare e non prediligere solo il gioco individuale davanti allo schermo, favorendo una socialità sana. Ci sono per fortuna tutta una serie di iniziative, ragazzi e bambini scoprono anche la piacevolezza di fare altre cose. Rispetto alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale nello studio, ci può essere un uso quasi esclusivo di questi strumenti potenti e promettenti da parte del singolo, per scoprire il mondo da soli, ci sono ormai app quasi su misura per ognuno. Può essere utile per recuperare un ritardo scolastico, ma poi un po’ solipsisticamente i bambini vengono condotti sempre più in questo caso ad un’idea di studio individuale, singolare, distinto e separato da un noi più largo, dalla cooperazione educativa, dalla cooperazione cognitiva che invece è la base per cui i bambini possono imparare insieme collaborando, ascoltandosi, aiutandosi. L’altra possibilità è anche studiare da solo, però poi questo studio individuale converga in regolari, costanti momenti di scoperta, di studio, di ricerca collettivi, cooperativi. L’altro grande tema delle nuove tecnologie è se sono una sfida del noi o se sono un’opportunità solo per l’io e questo si collega ai temi più generali che sono presenti anche nel Giubileo, ossia la scuola come fatto civile, che crea comunità: all’inizio della vita impari che è insieme che si raggiungono gli obiettivi comuni, che si impara a tenere insieme la società attraverso la coesione, che si risolvono i problemi tecnici, concreti, relazionali, e si scoprono insieme anche attraverso le diverse discipline come salvare il nostro pianeta e come procedere in concordia.
In un tempo dove gli egoismi, gli egocentrismi, i narcisismi personali sono così evidenti, nel Giubileo del mondo educativo vedo un’importante opportunità per dire che c’è anche un altro modo di essere utile per tutti noi che è anche bello e stimolante per ognuno.
Prima diceva che abbiamo fatto passi avanti sul fronte della dispersione scolastica, però non è un problema ancora risolto.
In questo momento noi abbiamo dati positivi che attestano che per la prima volta in Italia la dispersione scolastica vera e propria, cioè l’abbandono della scuola, è andata sotto il 10%, ed è la prima volta, venti anni fa stavamo oltre il 20%, quindi c’è stato un indubbio progresso, però questa è la media nazionale, poi non è così nelle periferie difficili, non solo del Sud, penso a Bari, Catania, Napoli, Palermo, Taranto, ma anche in quelle del Nord come Torino, Milano, Padova. La mappa è come al solito a macchia di leopardo e le parti più dense, dove persiste l’abbandono fisico dei circuiti scolastici e formativi, corrispondono con le zone più fragili, più povere del Paese. Inoltre, c’è un fenomeno che è la cosiddetta dispersione implicita che resiste moltissimo, cioè si frequenta la scuola, si è iscritti, non si abbandona formalmente, però si accumulano assenze, si è bocciati molti anni e alla fine i livelli di apprendimento reali sono molto bassi e questo ci viene attestato proprio dalle prove Invalsi, ma anche dalle prove Ocse-Pisa che le confermano: i giovani Neet delle aree povere sono molto più del 10% della media nazionale di abbandono scolastico, perché non hanno consolidato al tempo giusto neanche i saperi indispensabili in italiano, per esempio nella lettura, nella comprensione dei testi, nella scrittura corretta, in una conoscenza elementare di una seconda lingua, in particolare l’inglese, in geometria, geografia, storia, matematica di base, biologia. Magari finiscono il corso di studi, ma sanno pochissimo e, poiché il sapere si disimpara, quando facciamo le prove sulle conoscenze degli adulti troviamo un’ignoranza anche su cose basilari molto marcata. Affrontare le nuove tecnologie con una mancanza di conoscenze pone quesiti importanti in campo educativo perché tutto è complesso. Per un verso le nuove tecnologie disponibili sui device consentono un recupero. Per l’altro, si può essere in balia di fake news, di mancate verità, di sconclusionate conoscenze che diventano credenze assolutamente non sorvegliate, sbagliate o inesistenti, e quindi diciamo che bisognerebbe avere anche qui una politica pubblica per cui si possa recuperare, durante i primi anni della gioventù, mentre si lavora e nel mezzo delle sfide della prima età adulta, un corpo di conoscenze basilari da cui poi durante il corso di tutta la vita poter riprendere ad imparare. Anche questa dovrebbe essere un’occasione non solo per farlo da soli ma per farlo insieme agli altri, per esempio nei luoghi di lavoro o dentro le comunità, in modo tale che vi sia uno scambio, una circolarità, una complementarità di approcci, di sguardi, di ascolti reciproci che sono fattori importanti per imparare.
Ci vuole parlare della sua esperienza di maestro di strada?
È stato un seme molto utile. Adesso, a distanza di anni, vedo come positivo il fatto che gli educatori fuori da scuola, la famiglia e gli insegnanti lavorassero tutti insieme a favore del protagonismo di questi ragazzi che avevano abbandonato la scuola. In questa esperienza erano già in nuce le comunità educanti, si è trattata allora di un’intuizione oggi rilanciata nei tanti progetti del Fondo di contrasto della povertà educativa e dell’impresa sociale Con i Bambini che attua le finalità del Fondo: oggi abbiamo in giro per l’Italia centinaia e centinaia di partenariati che sono delle comunità educanti, che mettono insieme educatori, psicologi, assistenti sociali, pediatri, insegnanti delle varie discipline e con un’alleanza sempre più attenta con i genitori, dedicando tempo, metodiche e anche i luoghi comunitari necessari perché questo funzioni. Di quell’esperienza ho dei bei ricordi perché sento che siamo stati un po’ all’avanguardia e che ‘ avevamo avuto un’intuizione che oggi è alla base di tante esperienze educative tra fuori e dentro a scuola. Poiché continuo a vivere nello stesso quartiere di allora incontro adesso i miei alunni che fecero l’esperienza di scuola di seconda occasione e ora hanno 40-45 anni: vedo che parlano in italiano con i loro figli, che ci tengono che i loro figli vadano a scuola e quindi dico che abbiamo seminato bene.
Come si può fare in modo che i bambini e gli adolescenti di oggi non siano un’emergenza ma una forza per il futuro del Paese?
Il primo ingrediente, anche questo un tema del Giubileo, è dare fiducia. Le generazioni più vecchie consegnano il sapere ma devono consegnare anche il potere e la possibilità di effettivo protagonismo alle generazioni che vengono dopo.
E la base perché ciò funzioni è la fiducia, dando in mano la possibilità di fare, di sbagliare, di correggere i propri sbagli, di innovare e di fare le cose diversamente da come le faremo noi. Invece noi continuiamo a essere sospettosi, a parlare male di questi ragazzi, a non dare pienamente la fiducia. Certo ogni generazione ha fatto confronti, ma noi lasciamo a questi ragazzi un mondo peggiore di quello che abbiamo ereditato, scenari di guerra sempre più vicini, un debito pubblico, questo è il caso italiano, molto pesante, un continuo attacco ai valori cooperativi, una crescita dell’individualismo, del narcisismo anche con forme molto distruttive, fino alla cronaca nera. Quindi non siamo particolarmente titolati a dire che noi eravamo bravi e loro no, invece continuiamo a sentire parlare di Generazione Zero, di incompetenza, incapacità, pigrizia. I ragazzi, che fanno del male a se stessi e agli altri, vanno sicuramente sanzionati, ma dobbiamo pure guardare che i giovani di oggi imparano in maniera nuova, si impegnano per la salvaguarda del pianeta o della pace, fanno tanti lavori socialmente utili, cercano forme di protagonismo. Dobbiamo sottolineare gli aspetti positivi e dar loro fiducia, che io credo che sia questa la direzione e il messaggio che anche il Giubileo sceglie di sottolineare.
L’ultima cosa, quali dovrebbero essere secondo lei gli ingredienti di un patto educativo per il futuro?
Il patto nella mia esperienza è un processo, ci si mette d’accordo su un metodo, bisogna parlarsi chiaro, darsi dei compiti comuni e poi stabilire quali sono i compiti che spettano alla famiglia, quali alla scuola, quali ai luoghi dello sport o alla vita nella chiesa o al’attività sociale; infine,
The post Giubileo del mondo educativo. Rossi-Doria: “Dare fiducia ai giovani” first appeared on AgenSIR.mettere insieme i fili che tengono uniti tutti gli aspetti grazie a valori quali il diritto alla salute olisticamente intesa di ognuno, il rispetto per l’altro, il lavoro insieme, la cooperazione.