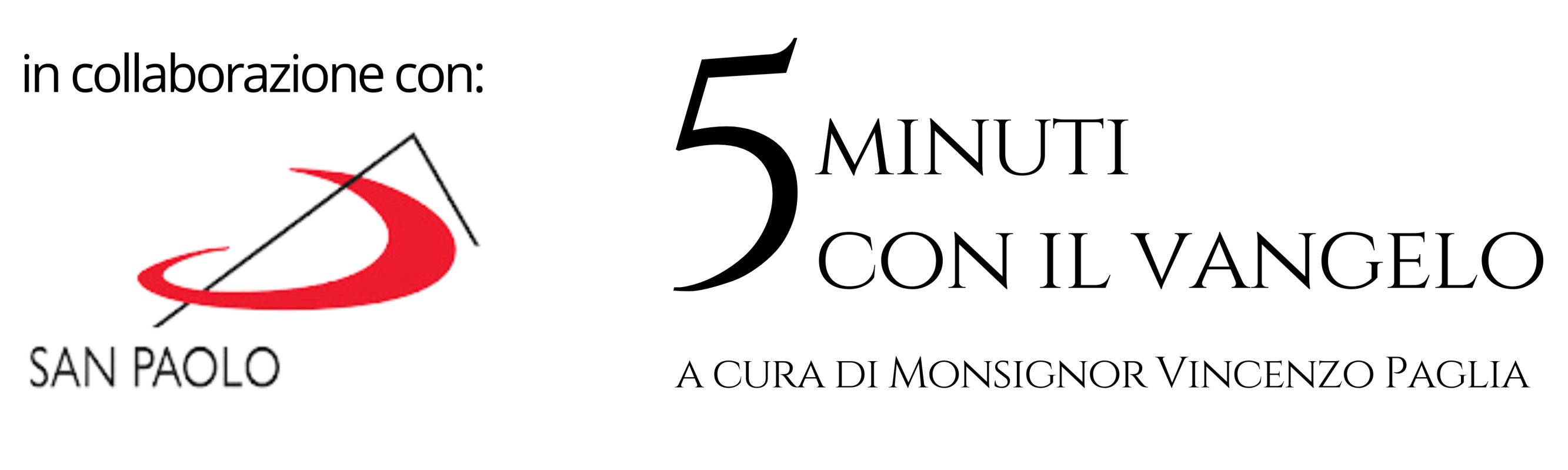Un devastante terremoto può diventare occasione per aprire uno spiraglio di bene. È quanto accade in Afghanistan, colpito alla fine di agosto scorso da uno dei peggiori disastri naturali nella storia del Paese. Il sisma ha colpito le regioni orientali di Kunar e Nangarhar, a Nord est della città di Jalalabad, facendo oltre 900 morti e tremila feriti, mentre la macchina dei soccorsi è apparsa subito inadeguata, indebolita dalla mancanza di mezzi e risorse finanziarie. Papa Leone XIV aveva fatto giungere un segno della sua vicinanza, assicurando preghiere per “tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia”, affidandoli “alla provvidenza dell’Onnipotente”, esprimendo “sincera solidarietà in particolare a quanti piangono la perdita dei loro cari”, invocando “consolazione e forza” per il popolo afgano.
Emergenza economica e umanitaria. Nella drammatica situazione, il governo dei Talebani ha inviato una richiesta di aiuto alla comunità internazionale e questa mossa è parsa agli osservatori una porta aperta per riconsiderare i rapporti dell’emirato islamico con le istituzioni internazionali e con le nazioni (inclusa l’Italia) che, dopo la presa di potere dei Talebani nel 2021, hanno lasciato il territorio, chiudendo le sedi diplomatiche. Da allora l’emirato ha ottenuto il riconoscimento da parte della Federazione Russa ed è riuscito a normalizzare i rapporti con i Paesi della regione, ma è rimasta la distanza con la comunità euro-atlantica, che contesta al regime le discriminazioni di genere e le violazioni dei diritti umani. Intanto la nazione fa i conti con la difficile realtà economica e sociale vissuta dalla maggior parte della popolazione, per l’aumento di povertà e disoccupazione. Ad aggravare la situazione, il fenomeno dei “rifugiati di ritorno”: dall’aprile 2025, oltre 100mila rifugiati afgani (per la maggior parte donne e bambini) sono stati rimpatriati da Iran e Pakistan, aggiungendosi agli 850mila rientrati all’ottobre 2024, mentre si prevede che ne torneranno altri due milioni. Secondo l’Unicef, oltre 28 milioni di afgani, per la metà bambini, hanno bisogno di assistenza umanitaria, mentre gli sfollati interni sono circa tre milioni e mezzo, al 50% minorenni: l’Alto commissariato Onu per i rifugiati definisce l’Afghanistan “una delle emergenze umanitarie più gravi al mondo”. A questa situazione già precaria si aggiungono le pesanti ricadute economiche dei terremoti del 2022, del 2023 e ora dell’ultimo sisma, in un Paese che prima del 2021, dipendeva per l’80% dagli aiuti dall’estero.
Onu, Ue e Chiesa cattolica. La missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama), attiva fin dal 2002, non ha smesso di portare avanti l’assistenza umanitaria, pilastro fondamentale della presenza dell’Onu in Afganistan anche con il nuovo regime. Uno speciale valore politico ha la decisione della Commissione europea, che ha stanziato 161 milioni di euro in aiuti umanitari per assistere i più vulnerabili, in aiuti alimentari, servizi sanitari, cure per la malnutrizione, attività educative soprattutto nelle aree remote. La mossa rappresenta un segnale di disgelo che potrebbe avere altri sviluppi in quanto, come ha riferito l’agenzia Bloomberg, nelle cancellerie dei Paesi europei si parla della possibilità di riaprire le sedi diplomatiche in Afghanistan, il che significherebbe il riconoscimento ufficiale delle attuali autorità afgane. A un’ambasciata, in particolare quella italiana a Kabul, era legata anche la presenza ufficiale di una comunità cattolica. Dal 1933 i padri Barnabiti tenevano aperta una cappella all’interno della sede diplomatica, dove celebrare i sacramenti e organizzare incontri per i fedeli cattolici, soprattutto tra il personale delle ambasciate occidentali, accanto a piccole comunità religiose come quella delle Missionarie della carità. Ma il 26 agosto 2021 padre Giovanni Scalese, barnabita e superiore della missio sui iuris dell’Afghanistan, l’unico sacerdote cattolico nella nazione, è stato costretto a rientrare in Italia, sancendo così la temporanea chiusura di una missione avviata dalla Santa Sede nel 1933.
La missione dei Barnabiti. A delineare lo scenario odierno, in un colloquio con Popoli e Missione, è padre Giovanni Rizzi, biblista e storico della congregazione dei Chierici regolari di San Paolo (detti Barnabiti), autore della monumentale opera “Ottant’anni in Afghanistan”, in cui narra con dovizia di particolari la straordinaria avventura della missione barnabita nel Paese dell’Asia centrale: “Siamo in una fase di paziente attesa – dice – che potrebbe durare anni. La missio sui iuris dell’Afghanistan eretta dalla Santa Sede nel 2002 tecnicamente è ancora esistente. Anche se, in assenza di una comunità cattolica nel Paese, è come se ora fosse sospesa. Ma nulla vieta che in futuro potrebbe riprendere a funzionare pienamente”. “Bisognerà capire – prosegue Rizzi – come si evolverà il rapporto dell’Afghanistan e la comunità internazionale e se si allacceranno nuovamente relazioni diplomatiche con gli Stati occidentali”. Quindi rimarca: “Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro e quali saranno i passi della Santa Sede. Certo è che l’esperienza di una cappellania cattolica in Afghanistan è durata oltre 80 anni e ha segnato la storia della Chiesa in quel Paese. È sicuramente una vicenda che va considerata su tempi lunghi”. Intanto, se diverse organizzazioni non governative come Save the Children, World Vision International, Care International e altre hanno dovuto sospendere le operazioni, dato il divieto imposto alle donne di lavorare nelle Ong, una realtà che ha resistito in Afghanistan, trovando un modus vivendi anche sotto il regime dei Talebani, è quella del Jesuit Refugee Service.
La presenza dei Gesuiti. In qualità di struttura organizzata dai Gesuiti dell’India, si è registrata come realtà impegnata nel campo socioeducativo e della formazione professionale, in attività scevre da qualsiasi connotazione religiosa. E così Bismillah, un bambino di 11 anni che non è mai andato a scuola, può frequentare il JRS Community Development Centre allestito in uno dei campi profughi nell’area di Kabul, dove segue lezioni scolastiche e può fare uno spuntino. La sua famiglia vive in rifugi allestiti alla meglio con teli e canne di bambù e la maggior parte dei 350 bambini che frequenta quel Centro educativo vive in situazioni simili. Dopo aver finito la lezione, nel suo “tempo libero” accompagna il padre alla ricerca di cibo per la giornata: l’obiettivo è provvedere almeno a un pasto al giorno per la famiglia. “Bismillah – raccontano gli insegnanti del Centro, indiani e afgani – ha iniziato ad esprimersi attraverso l’arte, il gioco, la lettura, la scrittura, trovandosi a suo agio nel Centro del JRS, uno spazio sicuro per lui”. E, nonostante le difficoltà quotidiane, “il ragazzo culla nel cuore il sogno di emulare il maestro che lo accoglie amorevolmente ogni giorno, divenuto per lui un punto di riferimento e un modello di vita”. Felice di avere l’opportunità di imparare, Bismillah dice: “Voglio anch’o insegnare ai bambini che, come me, hanno sofferto fame e mancanza della scuola”.
*Popoli e Missione
The post L’Afghanistan dopo il terremoto: nel Paese delle porte chiuse first appeared on AgenSIR.