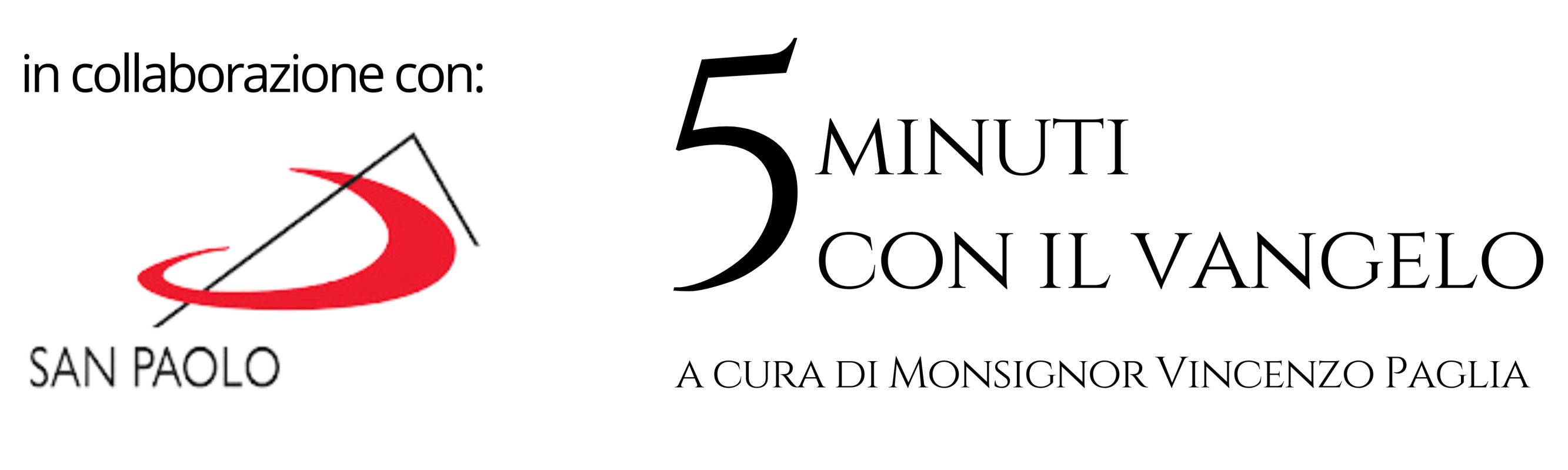La Nota dottrinale “Una caro. Elogio della monogamia” riapre il dibattito su unità, dono e appartenenza nella relazione coniugale, proponendo una lettura positiva e profonda del legame tra uomo e donna. In un tempo segnato da fragile stabilità affettiva, il documento del Dicastero per la Dottrina della Fede invita a riscoprire la promessa che fonda il “noi”. Con don Michele Ferrari, cappellano dell’Università Lateranense e dell’Istituto Giovanni Paolo II e docente di teologia morale, analizziamo contenuti, sfide e significati di un testo che rilancia il valore del matrimonio cristiano.
Il titolo della Nota richiama l’espressione “Una sola carne”. Quale prospettiva offre il documento?
La Nota parte dal contesto socio-culturale attuale, che fatica a comprendere l’amore come appartenenza reciproca e possibilità di crescita. Eppure l’uomo desidera ancora un amore esclusivo e capace di durare oltre i limiti del tempo. L’espressione “Una caro”, radicata in Genesi 2,24 e sviluppata dalla tradizione della Chiesa, è usata in senso positivo. Il sottotitolo introduce già un tono propositivo: un “elogio”, non un’imposizione morale. Si vuole mostrare la bellezza del dono reciproco e la possibilità concreta di una relazione che nasce da un impegno pieno e consapevole.
(Foto SIR)
Oggi sembra difficile scegliere un “per sempre”. È una fragilità solo culturale?
La difficoltà nasce da un contesto consumistico e ipermoderno che trasforma tutto in bene di consumo: sentimenti, emozioni, valori.
Ogni cosa deve essere veloce, immediata, sfruttata e poi superata. È una logica che influenza anche l’amore.
Questa dinamica culturale rende più complesso l’impegno nella relazione?
In un orizzonte dominato dall’istantaneità diventa difficile vivere la continuità. La Nota richiama la necessità di educare alla monogamia come iniziazione alla grandezza di un amore che supera l’immediatezza. È un cammino che richiede addestramento. Si tratta di crescere nel tempo dell’amore.
Il documento parla di “appartenenza reciproca”. Come evitare il rischio di leggerla come possesso?
Il Cantico dei Cantici offre una chiave preziosa: “Io sono del mio amato e il mio amato è mio”.
L’appartenenza reciproca non è possesso tirannico, ma un “possesso d’amore”.
Significa che ciascuno si sente dell’altro dentro una relazione di tenerezza e responsabilità, in cui il bene dell’altro diventa priorità.
In che senso questa appartenenza valorizza la libertà personale?
Non è assoggettamento. Il documento ricorda anche la possibilità di chiedere tempi e spazi personali. L’amore maturo rispetta la libertà dell’altro e riconosce la coscienza come luogo santo. È una dolce appartenenza, non una forma di dominio.
La Nota affronta anche poligamia e poliamore. Qual è la posizione della Chiesa?
La Chiesa è chiamata a una parola profetica. Profezia significa dire una verità che illumina la natura dell’uomo, anche quando è controcorrente. Afferma che
l’uomo è fatto per un amore esclusivo, unico, che corrisponde alla sua dignità e al suo essere creato a immagine di Dio.
Questa parola profetica si oppone quindi alle “mode” culturali?
È una posizione audace, perché si oppone alle mode quando non servono il bene della persona. La monogamia diventa manifestazione visibile dell’amore di Cristo per la Chiesa. È un annuncio che richiede coraggio e che indica un cammino di pienezza.
Parliamo di libertà. Perché oggi il matrimonio appare, a volte, come una limitazione?
Perché spesso si resta sul livello più basso della libertà, quella che sant’Agostino definisce libertà minore: scegliere tra alternative.
La libertà è invece un cammino. Cresce quando la persona dilata i suoi orizzonti, si decentra, mette al centro l’altro e ama.
Così diventa libertà maggiore: libertà amante. Il modello è Cristo che “avendo amato i suoi, li amò sino alla fine”.
La Nota richiama anche l’importanza della parola poetica. In che senso?
La poesia aiuta a sognare, a prefigurare cammini più grandi, a non fermarsi all’immediatezza. Profezia e poesia, insieme, aprono uno spazio più ampio alla relazione. Annunciare il matrimonio oggi è impegnativo, certo, ma necessario: l’uomo è fatto per amare così. La donazione reciproca fa fiorire l’umanità.