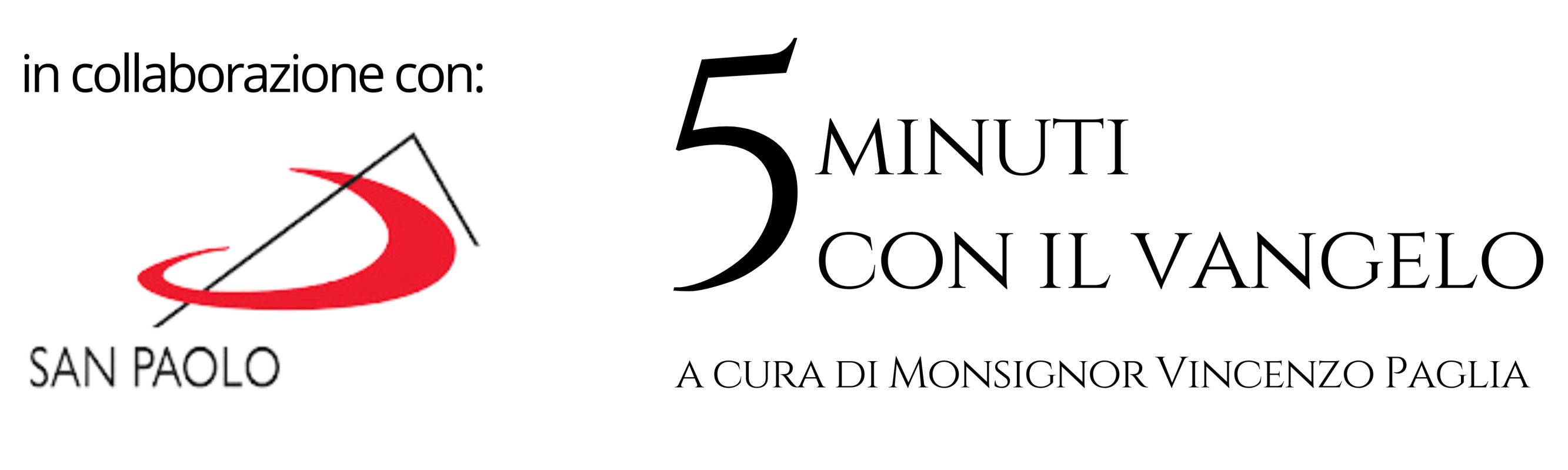“Annunciare il kerygma significa mostrare Cristo come liberazione”. Suor Benedetta Rossi, biblista e suora Missionaria di Maria, commenta il discorso di Leone XIV ai vescovi italiani, nel quale il Pontefice ha insistito sulla centralità dell’annuncio cristiano. Per suor Rossi, è la via per ritrovare unità interiore e svelare il volto di un Padre che cerca ogni persona in un tempo segnato da frammentazione e indifferenza.
(Foto SIR)
Leone XIV ha indicato il kerygma e la relazione personale con Gesù come cuore dell’annuncio. Che cosa significa oggi, concretamente, suor Benedetta?
Il Pontefice collega l’annuncio del kerygma alla necessità di rinnovare la trasmissione della fede, contrapponendolo alla frammentarietà culturale e sociale del nostro tempo. Per comprenderlo, tornerei al discorso di Pietro a Pentecoste, negli Atti 2, dove si enuclea il centro dell’annuncio cristiano: Gesù di Nazareth, morto e risorto. Ai versetti 22-24, la risurrezione è descritta come liberazione dai dolori e dal potere della morte.
Mettere al centro il kerygma significa testimoniare Gesù come colui che libera.
Questo annuncio offre una via d’uscita dalla frammentazione che, prima ancora di essere sociale, è interiore. Ritornare al kerygma permette a ogni cristiano di ritrovare unità in sé stesso e di vivere la piena statura di uomo o donna liberi, perché liberati dalla risurrezione di Cristo. La relazione personale con Gesù non è intimismo, ma un cammino verso la pienezza umana nella libertà che Cristo testimonia.
Suora Missionaria di Maria, biblista e docente di Sacra Scrittura, suor Benedetta Rossi è professoressa associata presso il Pontificio Istituto Biblico. Studiosa dei Vangeli sinottici e dell’ermeneutica biblica, si occupa di formazione teologica e di percorsi di catechesi biblica, ed è autrice di diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative sulla Parola di Dio come sorgente di libertà e vita per l’uomo contemporaneo.
È difficile oggi annunciare il Vangelo come buona notizia anche a chi è lontano?
Credo sia necessario tornare sempre a Gesù. Nel Vangelo di Giovanni (14,8-9), quando Filippo chiede “Mostraci il Padre”, Gesù risponde che chi vede lui vede il Padre. Qui si rivela la novità radicale: Gesù mostra un Padre che si prende cura, che cerca gli ultimi e i lontani, come narrano le parabole di Luca 15. Il pastore che cerca la pecora perduta, la donna che ritrova la dramma, il padre che attende il figlio: immagini rivolte a farisei e scribi che mormoravano dicendo “Costui accoglie i peccatori e mangia con loro”. Far sentire chi è lontano cercato e desiderato da un Padre che vuole la vita per ciascuno è la chiave dell’annuncio. Essere cercati è un desiderio profondo di ogni persona.
Il Pontefice ha parlato di portare “Cristo nelle vene dell’umanità”…
Questa espressione, ripresa da Giovanni XXIII nella Humanae salutis e rilanciata da Leone XIV, contiene due metafore. La prima: l’umanità come corpo, richiamando la solidarietà universale. La seconda: le vene portano il sangue, linfa vitale nascosta. Se il sangue si disperde, la vita si spegne. Cristo è questa forza vitale, invisibile ma generatrice. Come nelle parabole del regno in Matteo 13 – il seme di senape o il lievito – realtà piccole con forza trasformativa sproporzionata.
Portare Cristo nelle vene significa rendere consapevoli della forza misteriosa che anima la vita dell’umanità intera.
È Cristo che dà anima e vita non solo alla Chiesa, ma a ogni realtà umana intesa come corpo solidale.
Il termine greco “kerygma” significa “annuncio” o “proclamazione”. Nella Chiesa indica il primo annuncio della fede: la proclamazione di Gesù Cristo morto e risorto, vincitore sul peccato e sulla morte, vivente per sempre. È il cuore del Vangelo, la buona notizia che genera fede e conversione. Come ricorda san Paolo, “se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede” (1Cor 15,14). Il kerygma non è una dottrina astratta, ma un annuncio che libera, trasforma e apre alla relazione personale con Cristo, fondamento di ogni catechesi e missione.
Che tipo di Chiesa richiama questa immagine?
Una Chiesa diffusa, legata alle vicende del mondo, nascosta come il regno raccontato da Matteo 13, ma presente ovunque. Una Chiesa che non fa rumore, ma alimenta consapevolezza; che non cala dall’alto dottrine astratte, ma vive nella concretezza, rendendo visibile Cristo nella testimonianza quotidiana. Non si impone dall’esterno, ma manifesta Cristo come forza vitale che unisce e rigenera.
Leone XIV chiede anche di rinnovare la catechesi. Qual è la sfida per la Chiesa italiana?
La questione centrale non è moltiplicare strumenti pastorali o strategie sovraimposte. Forse, anzi, occorre asciugare esperienze e strumenti per tornare a quella Chiesa diffusa che appare nelle prime pagine degli Atti:
una comunità integrata nel tessuto sociale, che annuncia a partire dalle case e dalla vita quotidiana, attraverso uno stile di vita e l’amore reciproco.
Gesù, in Giovanni 13,35, offre un solo criterio per riconoscere i discepoli: “Da questo sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri”. È essenziale coltivare una Chiesa inclusiva, come lo Spirito è inclusivo, ricordando Pietro nell’incontro con Cornelio (Atti 10-11): “Chi ero io per porre impedimento a Dio?”. Tornare alle origini significa costruire comunità capaci di testimoniare l’amore reciproco come segno distintivo.
Questa prospettiva chiede di ripensare anche lo stile della catechesi?
Sì, credo sia necessario intenderla come testimonianza viva più che come trasmissione di nozioni. Annunciare Cristo significa mostrare, non semplicemente spiegare; rendere visibile nella vita concreta ciò che si è visto, udito e toccato. È una catechesi che nasce dall’ascolto del Vangelo e dall’esperienza di comunità che accolgono e camminano insieme, perché il Vangelo è buona notizia solo se diventa vita condivisa.
Nel discorso rivolto alla Conferenza episcopale italiana il 17 giugno 2025, Leone XIV ha sottolineato che il cuore dell’annuncio cristiano è il kerygma, invitando a rinnovare la catechesi per far emergere la relazione personale con Gesù come forza che libera e unisce. Ha parlato di portare “Cristo nelle vene dell’umanità”, spiegando che il Vangelo è linfa vitale per l’intera famiglia umana, chiamata a scoprire la fraternità e la speranza nate dalla risurrezione.