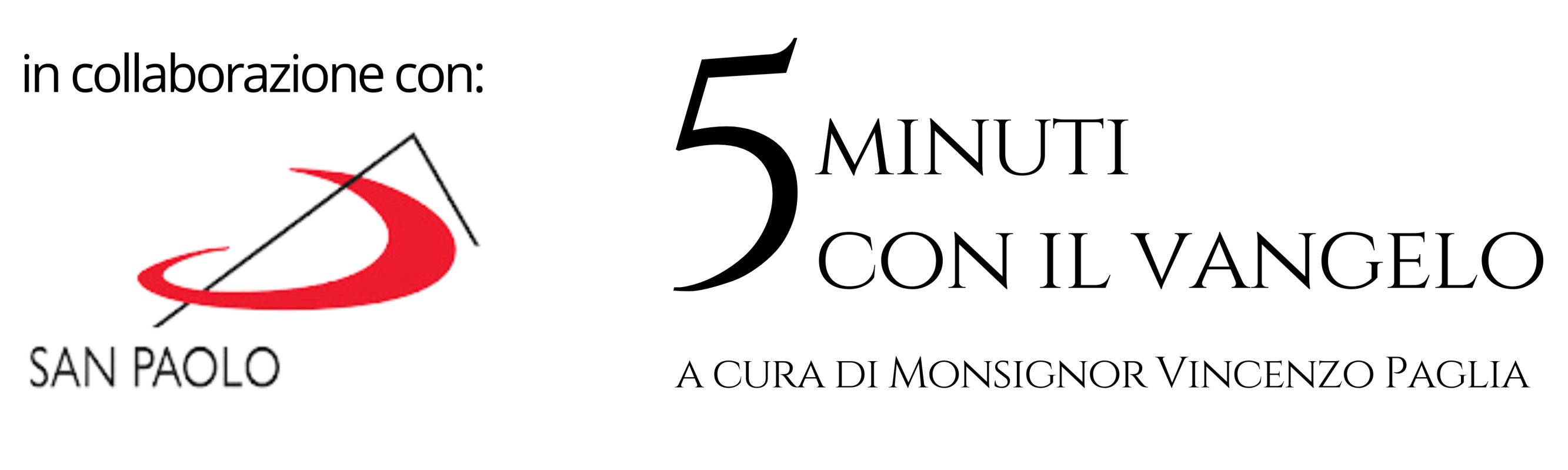In vista della Giornata mondiale e del Giubileo dei poveri, l’economista e saggista Luigino Bruni, coordinatore della Scuola di Economia Civile e tra i principali interpreti dell’“economia di comunione”, riflette sulla complessità del tema. In questa intervista al Sir invita a non ridurre la povertà a un problema di reddito: “È una faccenda di capitali e di relazioni”, dice.
Professore, la Chiesa si prepara a vivere la Giornata mondiale e il Giubileo dei poveri. Qual è la sfida più urgente nel parlare di povertà?
Quando parliamo di povertà nel mondo cristiano dobbiamo stare molto attenti, perché non è una parola semplice. Lo spettro della parola povertà è molto ampio: va dalla tragedia di chi la subisce e non la sceglie, fino alla felicità di chi la sceglie come via di sobrietà e libertà. Pensiamo ai missionari o ai religiosi: la loro povertà scelta diventa una strada di liberazione per chi la subisce. Per questo, nel mondo cattolico, dovremmo imparare a usare parole più precise: miseria, indigenza, esclusione. Se eliminassimo ogni forma di povertà, anche quella evangelica, la nostra terra sarebbe più povera. La povertà è la prima parola delle Beatitudini: non è solo una maledizione, è una via di felicità.
(Foto Siciliani-Gennari/SIR)
C’è però una povertà “cattiva”, quella che ferisce e che va contrastata. Come la definirebbe?
È la povertà che dobbiamo ridurre ed eliminare. Ma dobbiamo anche ascoltare un “magistero laico” che da cinquant’anni ci insegna molto. Economisti come Amartya Sen, Muhammad Yunus o Esther Duflo hanno mostrato che la povertà è una questione di capitali: sociali, familiari, educativi, sanitari, relazionali.
Quando questi capitali mancano, nasce la mancanza di reddito. Ma se si lavora solo sui flussi – cioè sul denaro – e non sui capitali, la gente resta povera.
Non basta avere reddito per sconfiggere la povertà. Coloro che hanno problemi di povertà sono le persone che hanno problemi di ‘capitali’, quindi non di reddito, ma di mancanza di cultura e di salute, di reti sociali. Ecco perché è molto difficile curare le povertà ‘cattive’. Invece, tutte le misure di povertà si limitano al reddito dimenticando che la povertà è anche una questione di ‘capitali’.
Cosa significa concretamente “lavorare sui flussi” e “lavorare sui capitali”?
Lavorare sui flussi significa dare soldi, redditi, sussidi. Io non sono contrario a misure come il reddito d’inclusione, ma se non sono accompagnate da un lavoro sui capitali – la scuola dei figli, la salute, le relazioni sociali, la comunità – non bastano. Altrimenti si rischia di avere persone che restano povere con qualche soldo in più, spesso speso male. Per ridurre la povertà bisogna lavorare sui capitali delle persone, non solo sui flussi. Se dai reddito a chi non ha capitali, quel reddito non solo si disperde, ma può anche fare danno.
Lei parla spesso di povertà come “faccenda di relazioni”. Cosa intende?
Dobbiamo uscire da una visione individualista della povertà. È anche una questione di relazioni malate. In Italia abbiamo inventato le cooperative sociali per aiutare chi usciva dal carcere o dalle comunità di recupero: li abbiamo inseriti in comunità, non lasciati soli. Dopo la riforma Basaglia, per la salute mentale si fece lo stesso.
Se non impariamo a guardare la povertà come una realtà collettiva e comunitaria, ma continuiamo a pensarla come uno status individuale, non usciremo mai davvero dalle povertà più serie.
Lei è tra i promotori dell’“Economia di Comunione”. In che modo questo progetto incarna un diverso modo di intendere la lotta alla povertà?
L’Economia di Comunione, nata nel 1991 da un’intuizione di Chiara Lubich, aveva capito tutto questo. Chiara non era un’economista, ma aveva un’intelligenza dell’amore. Diceva: ‘Aiutiamo chi non ha da mangiare, ma investiamo gli altri due terzi degli utili per educazione e formazione’. Da allora migliaia di giovani hanno potuto studiare e rafforzare i propri capitali – culturali, relazionali, spirituali – non semplicemente ricevere denaro. E tutto questo dentro comunità, non con aiuti ‘a pioggia’. È il segreto che tiene vivo il progetto da 35 anni: sostenere famiglie e persone senza creare dipendenza. Ricordo una ragazza brasiliana che vent’anni fa fu aiutata dagli imprenditori dell’Economia di Comunione: oggi, dopo la laurea e il dottorato, è responsabile del progetto per tutto il Brasile.
E, in questo quadro, come si inserisce il Giubileo dei poveri?
Temo che stiamo perdendo un’occasione. Il Giubileo biblico era un evento economico e sociale: significava remissione dei debiti, liberazione degli schiavi, restituzione delle terre. Noi lo abbiamo trasformato in un evento individuale e religioso, legato alla porta da attraversare o alla confessione.
The post Giubileo dei poveri. Bruni: “Lavorare non solo sui capitali, ma sulle relazioni. Così si può contrastare davvero la povertà” first appeared on AgenSIR.Ma se alla fine di questo Giubileo non avremo liberato almeno uno schiavo – dall’azzardo, dalle dipendenze, dall’usura – o non avremo rimesso qualche debito, allora sarà un Giubileo vano.